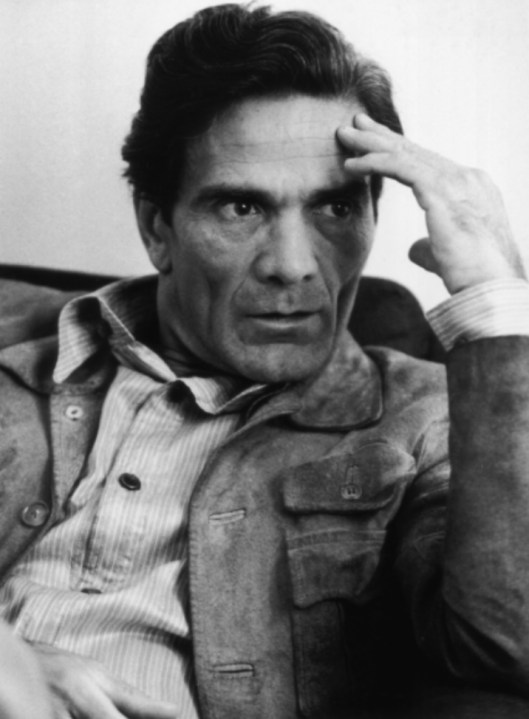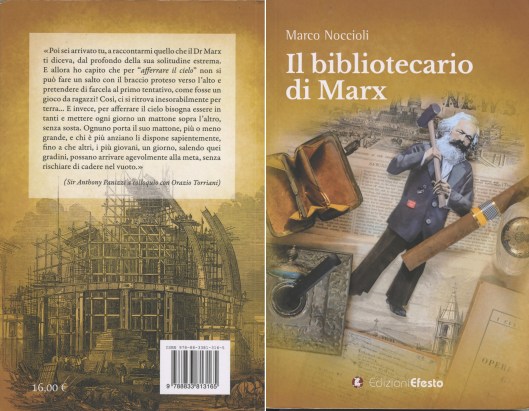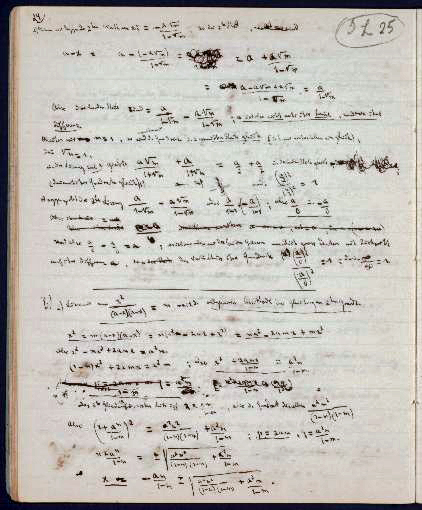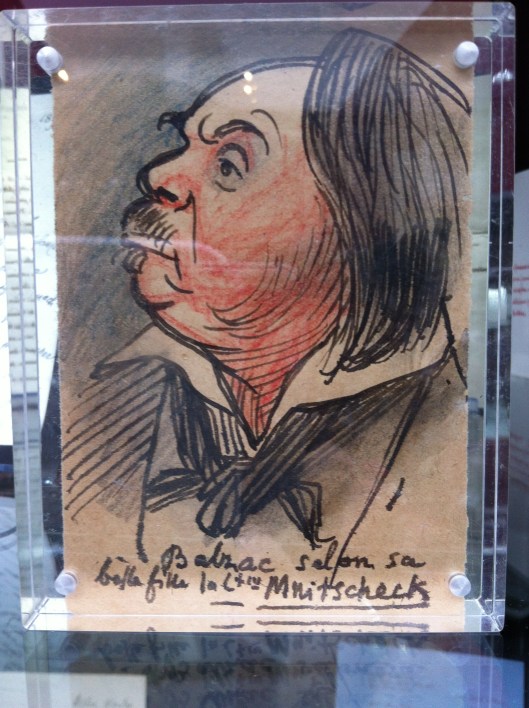Étiquettes
*
c’erano tutti sotto il sole bruciante
in attesa che la banda attaccasse
(in fondo allo spiazzo s’ergeva un muro
già in uso per le fucilazioni),
…….
e le parole svanirono e la musica forse
non ebbe inizio ma non avvennero fucilazioni
perché la guerra era finita da decenni
e ora tutti volevano vivere nella luce
I, VIII, pag. 14
Con la loro poesia-prosa densa e scorrevole, le “Mémoires di vite complici e confuse” di Loris Maria Marchetti (puntoacapo Editrice, 2024) sono una rara e speciale compagnia, una persona-vaso di Pandora (e anche vaso di preziosa porcellana dipinta) che nel raccontarsi suscita un sincero interesse sulla propria visione ed esperienza del mondo: un testo serio e profondo che sa essere anche molto divertente.
…e il perdersi non è perdersi e l’errare
stupiti ma non timorosi non è errare
fra incubi e spettri ma un trepido (quasi lieto)
tendere (un po’ purgatoriale) alla casa
del padre (Padre?)
I, VI, pag. 12
Vivendo stabilmente a Parigi, mi è venuto naturale, per prima cosa, correre alla Senna con le “Mémoires” sotto braccio, per un gemellaggio ideale tra questo fiume transalpino e il Po di Torino, e ho potuto constatare che le storie-punta (o coda) dell’iceberg raccontate da Loris Maria Marchetti vi scorrono senza troppe scosse, talvolta cercando di passare inosservate, talaltra facendo significative impennate. Questo è il mio sentimento generale.
la tempesta di vento era furiosa
e i mulinelli di polvere e foglie
ci travolgevano in plaza de Cataluña
e in plaza de España e ovunque cercassimo
rifugio — e mentre tentavo di coprirla
con il mio parka, Elena andava ripetendo
«tu non hai paura di niente,
mai nulla riesce a spaventarti»
Parerga, VI, pag.132
Poi, accomodandomi, con il libro in mano, sul parapetto del pont Mirabeau, immortalato da Apollinaire, così prossimo al “point du jour” di Parigi (là dove appaiono i primi bagliori dell’alba), mi sono messo a pensare, tentando di capire quale fosse il miglior criterio di lettura da adottare. Anche sfogliando le pagine a caso e contentadosi di dare una scorsa (come quando si è ammessi in un solenne museo o palazzo oppure invitati in una casa che trasuda vita e storia), ci si accorge subito della presenza significativa delle figure carismatiche e gentili del padre e della madre del poeta, presenti in delicati e struggenti ritratti o soltanto in effimeri passaggi, accompagnati dal sentimento di rammarico per la loro brevità:
dopo un cambio di treno, fra laghi incastonati
in oleografiche vallate, lasciandosi alle spalle
una Venezia merlettata e frammentaria dove mia madre
mi aveva salutato incamminandosi sull’acqua.
……
I, XIII, pag. 19
Raggruppare allora i ricordi-sogni della madre, quelli del padre, quelli delle storie surreali, quelli delle storie divertenti, e così via? No, ho chiesto consiglio ai poeti invisibili che vengono ogni mattina ad ispirarsi su questo ponte: niente raggruppamenti. Con una tale schematizzazione si rischia di fraintendere lo spirito autentico del retro-pensare o retro-sognare di Loris Maria Marchetti, il cui vero scopo è, invece, soprattutto quello di “fermare il bel momento” per rivendicarne l’irripetibilità e il distacco. Senza mai stracciarsi le vesti, senza mai (troppo) soccombere alla malinconia.
«Ma i malanni oramai sono passati, il cuore
si è rimesso» replicava impaziente
ovunque rovistando, spostando, ricercando,
sistemando i suoi oggetti con foga
come a riprendere possesso della vita
che era stata sul punto di lasciarla
II, XXIII, pag. 74
Tutto si inscrive nell’imperturbabile e inesorabile flusso della vita, come in un grande fiume. I singoli oggetti, i singoli relitti della memoria e del sogno — che io ritrovo qui, in un luogo lontano e separato ma caro al poeta e amico Marchetti — galleggiano o nuotano invisibili nell’acqua lambita dai primi bagliori del giorno. Essi si fonderanno poi, inseparabili, nel flusso del viaggio, diventando una beata sirena scaldata e poi scottata dal sole, o una tranquilla “péniche”, che, allontanandosi dalle anse di Parigi, continuerà a scivolare verso il mare delle “falaises”. Oppure, questo flusso di poesia pensierosa e sognante, con tutti i suoi grumi di inconsapevole gioia o strisciante dolore, viaggerà-navigherà controcorrente, avviandosi gloriosamente verso il sole di Notre Dame e dell’île Saint-Louis. Lì ci saranno altre copie delle « Mémoires di vite complici e confuse » in bella mostra negli scaffali dei bouquinistes, mentre delle sorridenti fanciulle bionde leggeranno ai passanti delle poesie a caso. Anzi, ciò sarà fatto a ragion veduta: una di loro attirerà l’attenzione dei presenti, cercando poi di convincerli, con il tipico atteggiamento “tranchant” dei francesi, che tutto è retto da un primordiale “égarement”. Secondo loro non ci sono possibili alternative: lo “spaesamento” fa da sottofondo a tutta l’opera di Marchetti, e a questo bellissimo brano in particolare:
in piazza Vittorio Veneto alla fermata del 56
incontrai Lucia in attesa del bus diretto in centro.
«E allora?» le chiesi. «Beh, mi metto al lavoro»
rispose col suo ironico sorriso siciliano.
Poi mi affrettai a guadagnare i portici verso via Plana
attraversando la piazza invasa dall’acqua
del Po straripato, che ormai arrivava ai ginocchi
Parerga XI, pag. 137
Senza rinunciare al mio indefettibile attaccamento alla letteratura francese mi aggrappo però, d’accordo con Marchetti, a due grandi maestri dell’“understatement” come Jacques Prévert e Raymond Queneau, e resisto all’ipotesi troppo sbrigativa, suggeritami all’ombra di Notre Dame. Perché, per entrare e accomodarsi nel testo di Marchetti come in un confortevole “abri” bisogna capirne la struttura. Al di là della evidente citazione dei tre canti della Divina Commedia di Dante — che serve a tracciare una parabola in cui Inferno, Purgatorio e Paradiso corrispondono a tre fasi della vita personale e poetica dell’Autore (ma anche, probabilmente, a tre diverse angolazioni visuali sulla commedia umana oramai vissuta e vista vivere in altre esistenze complici e confuse) —, queste “Mémoires” di Loris Maria Marchetti poggiano su due veri e propri “pilastri” formali e tematici, distaccandosi così dalle sue precedenti composizioni poetiche o in prosa.
Il ritmo e il sogno
Il primo pilastro è il ritmo, il tempo musicale e psicologico a cui il lettore deve potersi adeguare spontaneamente, se vuole leggere-ascoltare-capire-assaporare pienamente questo testo e trarne poi insegnamenti ed emozioni. Il ritmo con cui Marchetti restituisce narrativamente e poeticamente il disordinato e schizofrenico flusso della vita (con dentro l’eterno agguato della morte) si potrebbe, allora, identificare con il ritmo impresso da una voce particolarmente intonata (la sua stessa voce) che, dopo aver ricondotto lo sguaiato “can can” della vita a materia musicale omogenea, riesce poi a restituircene un’interpretazione armonica e allo stesso tempo unica, inconfondibile. Nel conferire, dunque, alla sua caratteristica voce di narratore-jongleur un timbro confidenziale e sempre ironico, Marchetti riesce a trasformare la raccolta e il collage di frammenti e momenti di diversa tonalità gravità e spessore in un’opera perfettamente e direi musicalmente compiuta.
la famigliola riunita
guardava la televisione
in perfetto silenzio stando a letto
(a sinistra la madre, come sempre,
a destra il padre, in mezzo il figlio ormai
maturo). A un certo punto compariva
in bianco e nero sullo schermo un complessino
che prendeva a suonare Quando calienta el sol:
in breve il figlio non riusciva più a trattenere
le lacrime e fra singhiozzi farfugliava
(non è ben chiaro se a sé stesso oppure ai suoi
che non battevano ciglio imperturbabili)
«trent’anni, trent’anni, lo capite?
sono passati trent’anni, sono passati trent’anni…»
III, XXIV, pag. 112
È a tutti noto che Marchetti ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la musica, classica soprattutto. Ma egli apprezza anche le belle canzoni. Riandando agli anni ’60, mi parlava per esempio di Sergio Endrigo, di Bruno Martino (autore della famosa “Odio l’estate”), di Franco Battiato, Paolo Conte, eccetera. Anche perché riconosce alla canzone d’autore un indiscutibile valore culturale, sociale e a volte anche politico: la stessa funzione aggregante — spesso più di contestazione che non di identificazione con miti e valori stantii —, che avevano i brani d’opera di Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini nell’Italia risorgimentale e post-unitaria. La “simpatia” che, dopo le prime due o tre letture, provocano vigorosamente i versi di queste “Mémoires di vite complici e confuse”, aumenta nelle letture successive perché, mentre qualche frase comincia ad entrare nella nostra memoria, agiamo nei confronti del libro né più né meno come se si trattasse di un disco a noi particolarmente caro. (Ciò mi fa riflettere ai comportamenti che ci vengono imposti oggi, così lontani da quella facilità “fisica” nel contatto-appropriazione, sia pur parzialissimo, con la “musica del cuore”. Lo stesso “riflesso condizionato” dell’immergersi nella musica delle canzoni non è più lo stesso, nella grave mutazione e involuzione culturale in atto, aggravata dai sistemi e metodi della diffusione del prodotto musicale e dell’organizzazione dell’ascolto quasi completamente sottratte alle iniziative indipendenti.) Mentre il libro di Marchetti è là. Non servono fili né ricariche. Lo si può leggere a voce alta o solo con la voce della mente: esso ci darà ogni volta una nuova emozione, come un vero quadro che, quando è frutto di vita e di sincerità, ha sempre qualcosa di nuovo da dire e da dare.
*
ieri mio padre mi cercò, mi chiese
se avevo un’ora per andare con lui
una domenica al ristorante. Gli dissi
alle undici e mezzo di domenica
prossima e si mise a ridere perché sa
che di solito pranzo molto tardi.
Voleva stare, credo, un poco insieme a me
perché a tavola c’è sempre troppa gente in quella
villa e non si riesce mai ad avere un attimo di pace
I, II, pag. 8
Il secondo pilastro è il sogno che, evidentemente, non è solo un accorgimento, un modo per riacciuffare la realtà vissuta o “fantasmée”, ma anche, soprattutto, in questo libro, la principale sostanza, più o meno trasfigurata, della narrazione. D’altra parte, il sogno non è evasione né gioco di parole volto a inseguire un viaggio insensato e favoloso, ma soprattutto filtro di una verità che è esistita e cerca di riprendere corpo e vita. Il sogno, dunque, è propizio al ricordo, che ritorna inevitabilmente travisato e relativizzato dalla natura frammentaria e dispettosa del sogno stesso. Nelle “Mémoires” di Marchetti l’io sognante si affida fiduciosamente al sogno (come in una seduta spiritica non troppo paurosa), perché solo così può instaurarsi un rapporto confidenziale con i morti (che appaiono in sogno come strani vivi o come vivi a metà) e con la morte stessa. Con il filtro del sogno la morte può addirittura diventare una festa:
sul vasto piano della massiccia
credenza Rinascimento fiorentino
lucida nera in sala da pranzo
posavano panini pizzette salatini
vol-au-vents. Li aveva procurati
Benedetta, dicevano,
ed era severamente proibito
allungare le mani anzitempo
II, XII, pag. 63
Il ritmo poetico si avvale dunque del sogno e viceversa: essi fanno un tutt’uno che diventa, quando il lettore è pronto a saltare su quel treno, un flusso omogeneo che equivale al racconto di un’intera vita e dunque all’affidamento benevolo (anche se sempre circostanziato e prudente) di tale vita ai lettori contemporanei e a quelli che verranno.
entrato di gran furia dal carraio
feci due giri del cortile, velocissimo,
quando, alzati gli occhi al terrazzo,
senza staccare le mani dal manubrio
vidi mia madre intenta a stendere
della biancheria. Come sempre provai
un forte brivido in quella circostanza
per la sua abitudine a sporgersi oltre
misura. E quella volta l’irreparabile trionfò:
perduto l’equilibrio, precipitò in cortile
avvolta nel lenzuolo che stendeva.
Ricordo solo il grido atroce e lacerante
che mi uscì dalla gola e l’impotenza
a scendere di sella e ad accostarmi
all’immoto viluppo silenzioso
III,VIII, pag. 95
Nel sogno di Marchetti, il ricordo è metabolizzato, smembrato e ricomposto in qualcosa che ci coinvolge, pur restando separato, al di fuori e al di là di una parete invisibile, che non è la membrana dell’occhio o del vetro, ma la percezione fisica, sottile e spaventosa, della separazione inesorabile che avviene, nella vita di ognuno, nel passaggio dell’addio, della partenza e della morte.
«sì» disse (in una stanza colore del vuoto e del dolore,
alla presenza di persone mute come fantasmi
diafani inconsistenti, ma forse non c’era
nessuno oltre me a raccogliere la voce)
«approfittàtene» (non disse così testualmente
ma il senso era questo) «sono io e sono tornato,
ma è per l’ultima volta e quando me ne andrò sarà
per sempre». Non disse nulla della sua nuova residenza,
ma l’aspetto lo sguardo la voce erano molto tristi: per via
della sua attuale condizione o per l’angoscia
di vederci e parlarci proprio per l’ultima volta?
Non lo sapemmo né allora né dopo
perché, fino ad oggi, ha mantenuto la parola
I, XVII, pag. 24
In molte delle poesie di questa raccolta il poeta Marchetti sembra viaggiare anche lui, come Giorgio Bassani, in una “Rolls Royce” che ripercorre la città (in questo caso Torino e non Ferrara) e rasenta i volti e le voci che furono vive nel presente della vera vita oramai lontana e perduta. Tutto ciò è vissuto come in uno stato di malattia e di consapevole diversità: la diversità di chi si trova già al di là della sottilissima membrana che protegge gli occhi, le orecchie, le mani e la stessa pelle come un “vestito” invisibile, che ci portiamo addosso e finisce per fondersi, nel corso del nostro invecchiare (senza mai diventare adulti), con il vestito di stoffa sgualcita della nostra “nonchalance” nonché della nostra “insouciance”, protettrice dei misteri più segreti.
mia madre mi telefonava
per avvertirmi che bisognava
sistemare le armi — ripulirle, riporle
o che so io. Di lì a poco salivo da lei
al quinto piano e trovavo le armi
in gran disordine, ogni tipo
di arma, antica e nuova,
in prevalenza pistole e rivoltelle,
ma non trovavo mia madre,
forse uscita nel mentre — sempre che
non avesse chiamato da altro luogo
Parerga, IV, pag. 130
Trovata questa chiave di lettura e scoperto che in questo libro essa è quasi una costante (ogni cosa avvenuta è perduta, anzi si allontana e si perde nell’attimo stesso il cui il poeta si sforza di ricordarla), il lettore si accorge che non è necessario, anzi, forse, sarebbe fuorviante, per esempio, dare eccessiva importanza alla chiave cronologica, nella lettura di questi frammenti (così densi, compiuti e “soli nella mente”).
già in automobile, mia dolcissima Elizabeth
(tu guidavi, io sedevo alla tua destra,
dietro di te c’era Vittorio ed al suo fianco
quel simpatico ragazzo americano),
ero sicuro che tu eri quella giusta
e che ti avrei adorato per la vita
Parerga, IX, pag. 135
La memoria del sogno è sì, molto spesso, il frutto o l’eco di avvenimenti più o meno traumatici o sconvolgenti, che “ritornano” in modo tanto perentorio quanto illusorio. Succede poi, a volte, che situazioni e personaggi “canonici” del nostro passato lontano (o lontanissimo) tornino insieme ad altri personaggi, del tutto estranei, affioranti di straforo, come altrettanti “imbucati”, da un passato vicino e più squisitamente “nostro”.
mia madre e sua sorella Matilde
parlavano della sorella minore defunta,
quel pomeriggio al ristorante, in tono
molto affettuoso ma anche assai oggettivo
(io mi chiedevo se avesse ancora un senso,
a conti fatti, quell’oggettività, considerando
l’infelice esistenza della morta,
ora semmai di fronte a ben più alto tribunale).
In un tavolo accanto, Ray Charles pranzava
con alcuni amici, mentre un registratore
trasmetteva molto forte senza sosta
brani del suo repertorio (morivo
dalla voglia di sapere quali cose
stesse ascoltando lui, nella sua cuffia)
III, XX, pag. 108
In ogni caso, per il lettore, ogni “evento” evocato è, inevitabilmente, fuori dal tempo, essendosi tra l’altro l’autore imposto di inscrivere i vari blocchi narrativi in modo “décalé” rispetto alle epoche della sua vita, che dunque raramente e solo in parte si possono legare a eventuali fatti precisi, se non agli accadimenti “esterni” nella Torino, Italia, Europa e mondo degli anni via via toccati:
in un clima festante (carnevale?
San Giovanni? uno scudetto del Torino?)
il piccolo corteo si snodava
lungo corso Regina Margherita
sui binari del tram verso il ponte sul Po,
entrambi i genitori, una sorella
della madre, il figlio (che chiudeva
la fila), tutti suonando, cantando,
ballando o reggendo in mano qualcosa –
all’imbocco del ponte si fermarono,
poi piegarono a destra, non passarono
il fiume, pur continuando a palesare
una perfetta condizione di letizia
III, XXXIII, pag. 123
Da un certo momento della lettura in poi, il lettore più appassionato comincia a provare la gradevole e un po’ inquietante sensazione di sognare la persona sognante e, via via, conoscerla in modo profondo ed esclusivo, come se il poeta Marchetti dedicasse intenzionalmente a lui soltanto, in un bar o in salotto, il racconto spesso minuzioso di “quello che è successo”, la descrizione viva di luoghi, personaggi, gioie inaspettate, traumi e sconvolgimenti che, attraverso il racconto stesso, diventano ricordo e sogno del ricordo. E non importa sapere se e in che misura colui che racconta sia stato attore unico o centrale o soltanto una figura coinvolta, “imbucata” in quello che si svela e poi sfuma.
non era mai successo, in tanti anni
di lavoro in comune e di amichevole
cameratismo, ma un pomeriggio ascoltando
musica del Sud-America (una bachianas
di Villa-Lobos, mica una lambada)
i loro visi si trovarono sempre
più vicini e le labbra finirono
per incontrarsi. Un bacio casto,
a dire il vero, quasi prudente, più affettuoso
che passionale, ma sempre un bacio.
Poi si recarono alla stazione
perché lei doveva partire e lui meditava
seriamente di prendere il treno con lei
III, XXI, pag. 109
Eros e Thanatos
Sta di fatto che rileggendo queste “Mémoires” — “viaggio di ritorno” in cui Dante e Virgilio si scambiano continuamente i ruoli — ci si accorge del peso addirittura schiacciante che hanno in esso le due grandi forze antagoniste che accompagnano, da svegli o da addormentati-sognanti, la nostra vicenda terrena: Eros e Thanatos. Con un paragone calcistico (pensando con Marchetti al Torino e non alla Juventus), potremmo dire che qui, in questo libro, la squadra del Thanatos è sempre all’attacco, anche se spesso “confusamente” e senza grande incisività. Di goal ne ha fatti già tanti, e per la sua indole e natura continua a imperversare, ma a volte sembra contentarsi soltanto di fare paura. D’altra parte, la squadra dell’Eros, tipicamente italiana, è molto ben attrezzata in difesa ed è imbattibile nel contropiede. La revanche amorosa, l’ebbrezza dell’incontro incredibile, paradossale e casuale, fa così da contrappeso sdrammatizzante a situazioni minacciose o ad incontri solenni con gli scomparsi (la madre, il padre, una zia, il padre di un amico, eccetera) e spesso l’incursione salvifica dell’eros è accompagnata da una folgorante comicità:
non era male come ospedale o clinica,
……
e l’evasione, propiziata da Giuliana (senza la quale
nulla avrei potuto), avvenne attraverso una finestra
con il solo pigiama addosso. Mi misi poi alla guida
di una spider e percorremmo tutto corso Raffaello
rispettosamente sulla destra ma correndo
all’indietro a gran velocità…
I,XVIII, pag. 25
C’è poi il filone autobiografico, accuratamente nascosto tra le righe dei versi, in cui Marchetti — senza mai discostarsi dalla regola della “confusione”, rivendicata nel titolo, grazie alla quale nessuno può dire con assoluta sicurezza che è di lui che si parla, che è lui che parla di sé —, celebra, con la sua, la temeraria-saggia e ubbidiente giovinezza (unica e irripetibile) della sua/nostra generazione, con tutto il connesso travaglio psicologico, sentimentale, morale e (segretamente o palesemente) fisico che non fu esente da incertezze e sofferenze, ma anche da gioie totali e insperate. Dunque anche, inevitabilmente, dai contraccolpi delle separazioni e degli addii:
entrato furioso nel famoso caffè
….
…solo gli riuscì di intravedere
una folta chioma fulva («è lei, è lei!»)
in intimo colloquio con uno sconosciuto.
Non osò avvicinarsi, ma gridando
«è finita, adesso è davvero finita»
imboccava un corridoio interno del locale
percorrendolo tutto in una corsa esaltata
che sembrava non avere mai fine,
davvero non avere mai fine
III,III, pag. 89
Chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscere di persona Loris Maria Marchetti e di ascoltarlo raccontare con rabdomantica efficacia pezzi di vita sua e non sua, come se fossero aneddoti più verosimili che veri, lo ritrova senz’altro in questo stupore esistenziale, fanciullesco ed eterno (in cui ritrovo spesso la mia similare o identica esperienza): «Viviamo e soffriamo, ci troviamo coinvolti in azioni e situazioni a catena, che fummo, chi lo sa? magari noi stessi a determinare. Ma eravamo davvero noi, quelli?»
al Regio cercavo con inquietudine crescente
il mio posto numerato che sembrava non esistere
dissolto nella giungla delle poltrone rosse
tutte uguali, finché, riuscito a conquistare
un posto laterale di proscenio, ancora
in piedi mi misi a leggere il programma
…venendo subito
inquadrato da una telecamera: invano
con energici gesti mi sforzavo a far intendere
all’operatore che non ero io lo speaker
ufficiale da riprendere e da mandare in onda,
ma il regista stesso, materializzatosi d’incanto
non si sa da dove, gridava che non gliene fregava
niente, che andava benissimo chiunque leggesse
il programma ad alta voce (anche uno sconosciuto),
perché il concerto stava ormai iniziando
e non c’era tempo da perdere in quisquilie
II, XIV, pag. 65
Mi era, per finire, venuta un’idea che ho subito abbandonato, perché avrebbe travalicato il mio compito di lettore-osservatore: prendere un solo verso da ogni singolo componimento, e poi costruire con i 100 + 13 totali (di dantesca strutturale memoria, come si è detto), un poemetto fuori sacco, naturalmente diviso in quattro parti, in cui ri-raccontare il più fedelmente possibile lo straordinario poeta e amico Loris Maria Marchetti.
non c’era anima viva nei pressi
di Torino Esposizioni quel pomeriggio
torrido e desolato di primo agosto,
nemmeno un’auto, ad eccezione della sua,
unica in vista, la ruota posteriore
sinistra frantumata dopo l’urto
contro la sola palina esistente
nello spazio di centinaia di metri…
Tuttavia fece in tempo ugualmente
a consegnare a Stefano il manoscritto
del commento a Carducci, che lui
avrebbe letto con calma nel corso
del mese, tanto, quell’estate, non era
certo il caso di parlare di vacanze
II, XVII, pag. 68
Giovanni Merloni