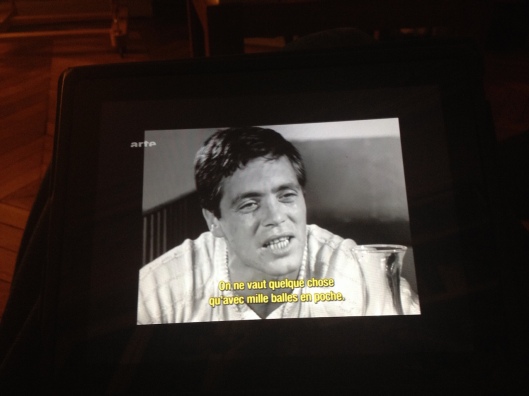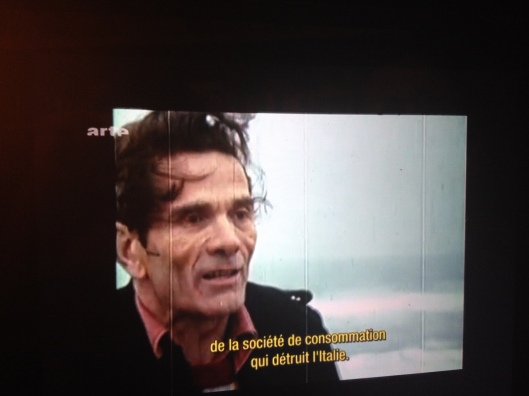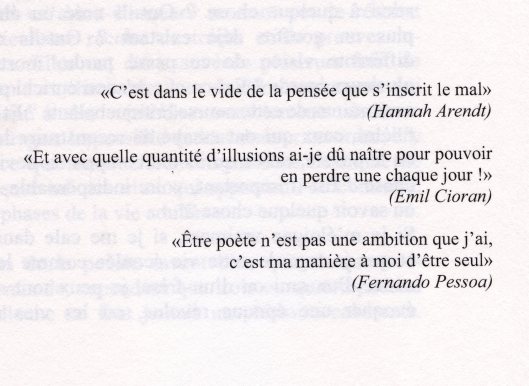Étiquettes
«Vi auguro di rispettare le differenze degli altri,
Perché il merito e il valore di ciascuno sono spesso da scoprire.
Vi auguro di resistere all’insabbiamento, all’indifferenza
e alle virtù negative della nostra epoca…»
Jacques Brel
Nella mia mente incapace di reagire eppure affascinata dai misteri, si insinua ogni notte, ormai, la paura di dimenticare quello che ho appena capito nel bel mezzo del sogno: un sogno destinato peraltro a essere inesorabilmente cancellato.
Ci sarà sempre un interlocutore, un destinatario che condividerà le rivelazioni del mio viaggio nell’incoscienza e non dirà niente di quello che ha visto e capito standomi vicino.
Tuttavia, sapendo che lui conosce la spiegazione del mistero, gli affido il compito di aspettarmi là, vicino alla porta: quest’ombra travestita da essere umano mi aiuterà di certo nella penosa ricostruzione della mia splendida verità o allora della traballante trama dei miei sogni tenaci.
Stanotte agiva su di me il rimorso per aver subito passivamente la valanga dell’auto-rappresentazione reciproca, imposta, da Facebook e Whatsapp in particolare, ancora una volta in occasione della fine dell’anno: come fanno tutti, ormai, anch’io ho inviato — prima a benevole persone di famiglia, poi ad interlocutori più sensibili e pronti a scattare, urtati magari dalla mia innocente vetrina di oggetti quotidiani — fotografie senza storia che per di più risentono, inevitabilmente, del peso dell’esistenza.
Per ogni ritratto, invece, bisognerebbe prepararsi in anticipo, oppure avere quella sicurezza innata e assoluta che permette, a chi ce l’ha, di “bucare lo schermo”: un talento che solo i grandi attori o i grandi impuniti sanno tenere in allenamento.
Dall’altra parte della macchina fotografica ci deve poi essere qualcuno che conosca a fondo l’arte di captare a nostra insaputa le nostre espressioni più fedeli. Se è per esempio Wim Wenders colui che ci spia ed “estrae” abilmente i tratti essenziali del nostro volto fuggitivo o assente, — assorto in pensieri definitivi oppure spaesato per l’assenza di vere riflessioni —, il nostro ritratto sarà efficace anche se l’immagine sarà sfuocata o mossa, o anche immersa in un chiaro-scuro portato alle estreme conseguenze dalla scelta di colori troppo accesi o brutali…
Care A* E* I* O* e U*,
Esattamente nove mesi dopo la mia ultima pubblicazione, comincio con voi un resoconto sotto forma di lettera, che sarà seguito da altri scritti similari, che saranno inviati di volta in volta ad ognuna di voi. Da voi mi aspetto la stessa indulgenza que in altre occasioni mi avete dimostrato, la stessa attenzione distratta che è stata sempre capace, anche da sola, di darmi la forza di portare avanti una simile avventura.
«Di che si tratta?» mi domandate. «Perché hai smesso così rudemente di darci del tu?»
Si tratta di rompere una spessa cappa di silenzio indurito, che ha assunto, col tempo, il carattere di altezzosa impenetrabilità di un Palazzo dei Papi dalle immense sale vuote, dove, da alcuni mesi — tranne i pochi addetti al controllo dei sistemi di sicurezza —, nessuno ha il diritto di avventurarsi.
Il mio racconto dei mesi appena trascorsi sarà inevitabilmente frammentario e incompleto. Innanzitutto perché non si può dire tutto e spiegare tutto. Io condivido poi, con tutti i mei corrispondenti, il silenzio di cristallo di questa interminabile battuta d’arresto, e ciò ha dato vita a une società sotterranea piuttosto orgogliosa dei suoi segreti. Infine, non è corretto lamentarsi, almeno fino a quando avremo la fortuna di sopravvivere: la cosa più importante in fin dei conti.
Ecco, mie care amiche, l’interstizio attraverso il quale osserverò d’ora in poi queste lunghe giornate di trepidazione e di solitudine passate e future: uno specchio di Alice che il mio isolamento personale e familiare non ha mai smesso di attraversare, generando abitudini, piccoli vizi, nostalgie e sogni.
Ed ecco una delle ragioni per cui mi rivolgo a voi cinque: tre di voi siete mie compatriote, voialtre due siete innamorate dell’Italia! Sta di fatto che al di là dei riquadri della mia finestra il viale parigino si lascia volentieri rimpiazzare dalle montagne e dalle acque che ci dividono gentilmente e senza scosse da quest’altro paese d’Europa colpito per primo dalla pandemia con una spaventosa concentrazione di lutti e di minacce che seminavano riguardarlo in modo esclusivo.
Grazie alla gratuità di “Free” e di “Wathsapp”, i miei rapporti con l’Italia sono molto cambiati rispetto agli anni precedenti: insieme alle telefonate, la corrispondenza affidata alle mail è da allora diventata la mia compagna quotidiana.
Se da una parte vivevo isolato in una Parigi trasfigurata, che mi diventava ancora più cara, i mille ponti virtuali, vocali o telepatici che mi raccordavano alle mie famiglie d’origine, mi obbligarono a mettere provvisoriamente da parte il mio francese d’elezione e riprendere con gran lena la mia lingua materna.
Con i miei corrispondenti — di Torino, Milano, Bologna, Genova, Perugia, Roma e Napoli — si parlava soprattutto della pandemia oppure dell’Europa durante e dopo la crisi sanitaria: «Chissà se l’Europa riuscirà a riavvicinare i paesi che la compongono; a valorizzare sul serio l’immenso patrimonio artistico prodotto nei secoli da ognuno di loro… Che ruolo avranno in essa le differenti lingue e culture letterarie?»
Per l’Italia, le tre circostanze combinate della pandemia, del Brexit e della caduta di Trump potrebbero cambiare le cose. D’altronde, l’ubriacatura mitologica e tecnologica del modello anglo-americano ha ormai toccato la vetta più alta: essa si relativizzerà davanti alla prospettiva, in Europa, d’un nuovo slancio socio-economico e culturale che non potrà trascurare la crescente domanda di uguaglianza e di giustizia sociale
Ma quanti anni o secoli dovremo aspettare prima che una solida cultura europea circoli veramente da un paese all’altro secondo il nobile principio dei vasi comunicanti?
Accanto all’ottimismo della volontà federativa bisogna riconoscere una qualche dignità al pessimismo della ragione quando si deve constatare che un tale travaso di risorse e patrimoni si verifica molto sporadicamente, anche meno che nel passato, tra Francia e Italia.
Uno dei simboli più rappresentativi degli scambi reciproci tra i nostri due paesi è il famoso Palatino, il treno di notte che ha avvicinato per decenni Roma a Parigi: protagonista tra l’altro di uno straordinario romanzo di Michel Butor —
“La modification” — questo fondamentale “link” è stato soppresso.
Nel criticare questa decisione — dovuta meno a un malinteso diplomatico che alle politiche ferroviarie dei due paesi che apparentemente decisero di abolire questa linea in funzione del progetto della rete internazionale dell’Alta Velocità e del TGV francese, lungi dall’essere compiuta tra Torino e Lione come tra Genova e Nizza — ci si interroga anche sulle ragioni che fino ad oggi impediscono o comunque non favoriscono lo sviluppo, tra i miei due paesi, di scambi culturali effettivi, sistematici e non soltanto formali.
Storicamente, si può dire che la Francia ha vissuto fino in fondo sia il potere schiacciante dei Re sia quello sanguinario della Rivoluzione; mentre in Italia, dalla notte dei secoli, oltre alla costante presenza dei Papi, c’è stata sempre una vasta costellazione di Poteri in lotta tra di loro.
Questa differenza strutturale — geografica e storica — dà inevitabilmente luogo a due culture diversamente strutturate, per quanto riguarda la lingua, il patrimonio, i contenuti e le forme letterarie e artistiche che si sono via via imposte.
Se in Francia si assiste ad una certa rigidità e intransigenza nella difesa ad ogni costo della lingua nazionale, in Italia si è sempre riconosciuta l’importanza dei dialetti, considerati essi stessi come vere e proprie lingue. Basti ricordare il teatro veneziano di Carlo Goldoni (1707-1793), quello genovese di Gilberto Govi (1885-1966) e quello napoletano di Eduardo De Filippo (1900-1984): teatri e culture che nulla levano al prestigio dei poli culturali di Torino, Milano, Bologna, Roma come della Sicilia, dove i rispettivi dialetti sono anch’essi riconosciuti e valorizzati.
Questa ricchezza discende dall’estrema parcellizzazione geo-politica della nostra penisola fino all’unità nazionale, compiuta il 20 settembre 1870, cioè 150 anni fa, molto di recente, mentre l’unita della Francia può vantare almeno dieci secoli, se non vogliamo risalire a Carlo Magno… Bisogna poi considerare che in questo tempo così ridotto la nazione italiana ha subito, con le due guerre mondiali e il fascismo, un pesante rallentamento nella sua evoluzione economica, sociale e culturale che gli anni successivi alla Liberazione del 1945 non sono bastati a recuperare in modo soddisfacente.
In una delle prossime lettere, parlerò del ruolo della televisione nella profonda trasformazione culturale dell’Italia, caratterizzata tra l’altro da un fastidioso miscuglio di dialetti che rischiano di perdere la loro identità o se si vuole, da un gran calderone in cui la lingua italiana, contaminata dai dialetti e accresciuta dalla creatività dei popoli si alimenta sempre più di parole ed espressioni importate dalla lingua (soprattutto tecnologica) degli Stati Uniti.
In definitiva il diverso atteggiamento delle istituzioni culturali della Francia e dell’Italia riguardo alla lingua nazionale e ai dialetti è uno dei principali fattori di incomprensione tra francesi e italiani.
Una piccola traccia di una serie di malintesi “culturali” tra questi due “grandi popoli” la di può ritrovare nella diversa concezione della “comicità” nella scena teatrale e cinematografica in ciascuno dei due paesi.
Se si considera per esempio il mio entusiasmo e la mia ingenua disponibilità a stupirmi e ad ammirare senza limiti le cose “fatte a regola d’arte” à règle d’art”, in Italia sono considerato un sognatore che non ha capito niente della vita, mentre il Francia rischio di essere additato come un “tipo ridicolo” che ambisce a cose che non gli appartengono.
Recentemente, a breve distanza, ho avuto l’occasione di vedere due film in cui la figure del “borghese gentiluomo” era al centro della narrazione.
Questo personaggio mi ha fatto ricordare di un famoso film, precedente, in cui Yves Montand prendeva lezioni di teatro nella speranza di conquistare l’affascinante e inafferrabile Marilyn Monroe: in questa storia, risulta in po’ patetica la goffaggine dell’uomo ricco che prende inutilmente delle lezioni di naturalezza, anche se alla fine egli raggiunge il suo scopo.
Nelle interpretazioni del borghese gentiluomo, incarnato nel primo film da Michel Serrault e nel secondo da Fabrice Luchini, si arriva a capire, una volta per tutte, la nozione di “ridicolo” che il teatro e la vita di tutti i giorni, in Francia, ereditano dalla eterna “regola del gioco” che regnava alla corte del Re Sole e regna ancora oggi nelle piccole e grandi “nicchie” dove si esercita il potere, compreso quello culturale.
Nel borghese recitato da Michel Serrault (1968) il ridicolo risiede meno nella sua passione impossibile per la marchesa Dorimène che nella sua ambizione di essere considerato un gentiluomo. Nonostante le magnifiche invenzioni che Serrault aggiunge al personaggio di Molière con un’interpretazione surreale e auto-ironica —, il suo borghese gentiluomo cozza contro il muro del potere assoluto in un’epoca in cui la Rivoluzione è ancora molto lontana.
Nell’interpretazione di Luchini (2007), si assiste ad una situazione molto differente, che si potrebbe intitolar “la vera storia del borghese gentiluomo”. Salvato dalla prigione (dove languiva per i debiti accumulati) da un ricchissimo borghese, il giovane Molière è invitato a mettere in scena una commedia che costui aveva scritto senza averne l’ispirazione né le capacità. Sottraendosi all’obbligo della fedeltà assoluta al testo del grande drammaturgo del XVII secolo, la sceneggiatura di questo secondo film tiene conto del rovesciamento storico operato nella società francese dalla Rivoluzione francese (1789-1794). Dunque, se il borghese è ridicolo in tutto ciò che gli è fondamentalmente estraneo, la nobiltà spendacciona, anzi in rovina con cui egli cerca di imparentarsi è, anch’essa, scandalosa nella sua assoluta mancanza di spina dorsale.
Col tempo, la concezione italiana della comicità, molto complessa e diversificata, ha dato luogo, tra l’altro, ad un uso sempre meno sopportabile della derisione, pesante e spesso volgare, che spesso sottintende un’ammirazione servile e del tutto acritica dei vincenti, senza fare alcuna differenza tra le persone oneste e disoneste.
Sennò, in Italia come in Francia, pareti invalicabili separano i “popoli eletti” da coloro che restano fuori. E la commedia umana, di cui Molière è uno dei padri più illuminati, si traduce dappertutto in questo incredibile spreco di energie vitali che consiste nel far finta di credere o di non credere alle “regole del gioco” secondo le situazioni e le convenienze.
Nelle lettere che riceverete, sarà sviluppata una riflessione su questi temi, allo scopo di aggiungere qualche testimonianza al quotidiano dibattito culturale tra le nazioni-sorelle d’Europa e, in particolare tra la Francia e l’Italia.
Nella consapevolezza di poter superare, almeno a livello personale, ogni sentimento di frustrazione per le possibili incomprensioni tra le mie due patrie, ho deciso di riprendere le mie pubblicazioni sul “ritratto incosciente” : il rapporto con la lingua e la cultura francese è, per me, un rapporto d’amore da cui nessuno potrà distogliermi.
Giovanni Merloni
Testo in FRANCESE